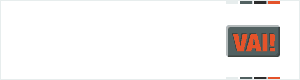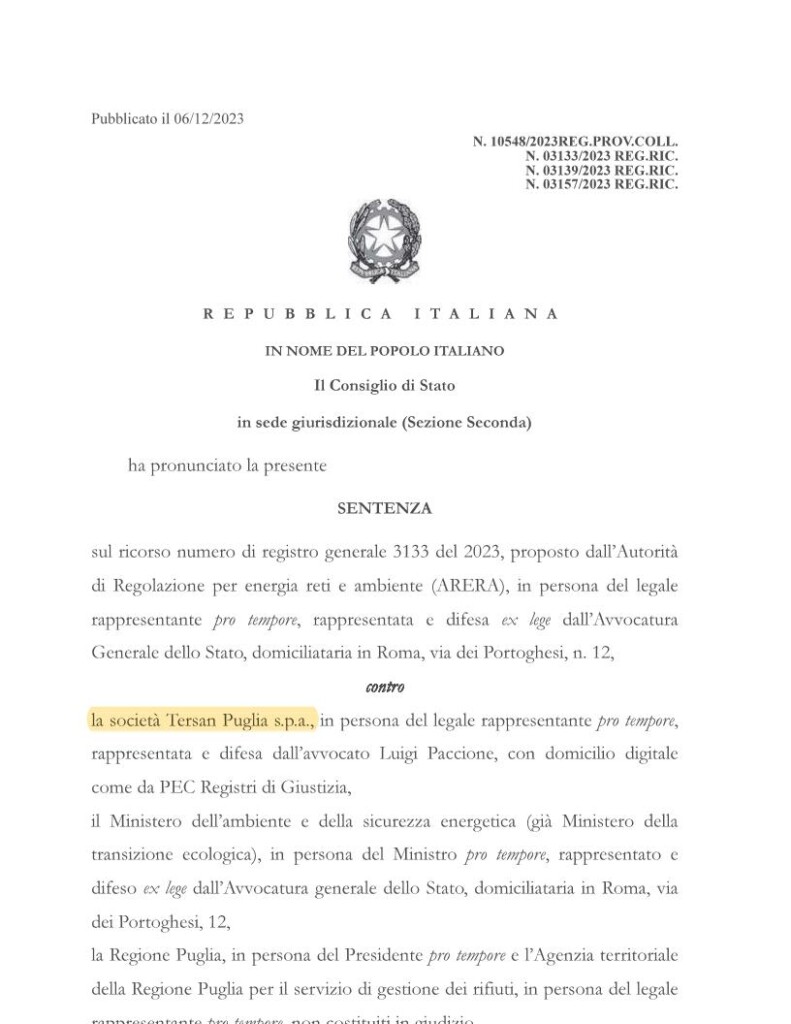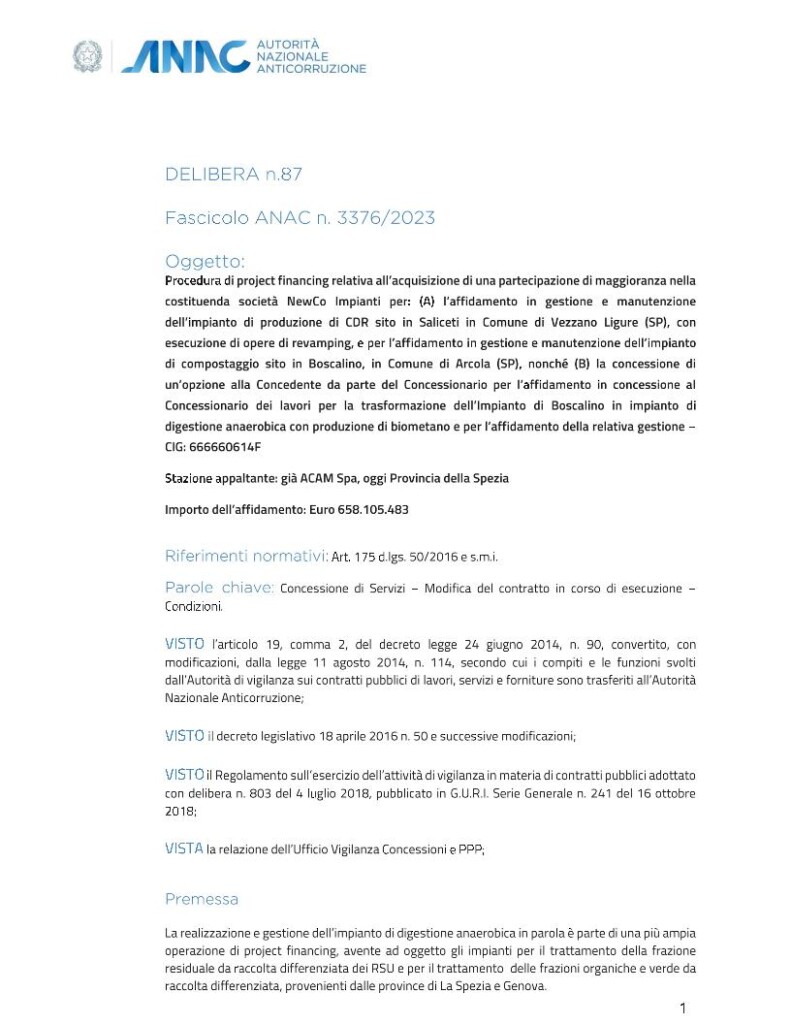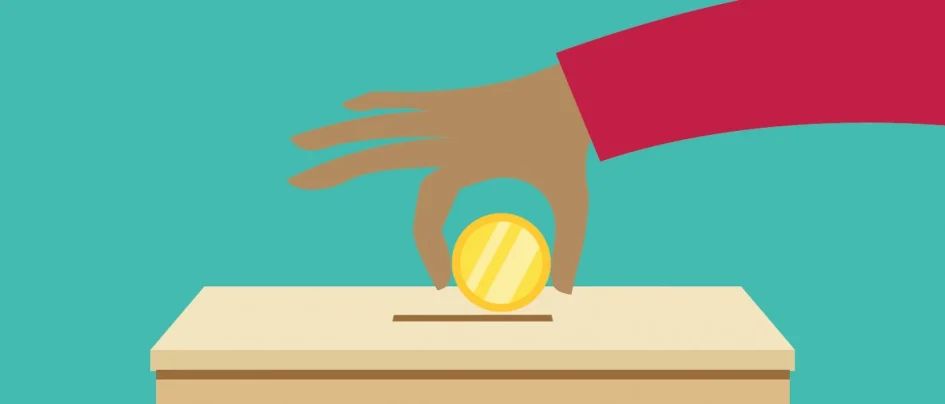Mario Botta visto da Paolo Portoghesi
Ascesa e inaridimento di un grande maestro
 Pubblichiamo due pagine del libro di Paolo Portoghesi, guru dell’architettura mondiale, dedicato ai grandi architetti del Novecento. E’ del 1998. Portoghesi inserisce Mario Botta tra i grandi maestri del Novecento. Ma ne delinea i limiti, la parabola, rispetto alla sua produzione degli anni Ottanta. Non è vangelo. Ma le argomentazioni, tutt’altro che superficiali, sono uno stimolo a una riflessione non affetta da provincialismo.
Pubblichiamo due pagine del libro di Paolo Portoghesi, guru dell’architettura mondiale, dedicato ai grandi architetti del Novecento. E’ del 1998. Portoghesi inserisce Mario Botta tra i grandi maestri del Novecento. Ma ne delinea i limiti, la parabola, rispetto alla sua produzione degli anni Ottanta. Non è vangelo. Ma le argomentazioni, tutt’altro che superficiali, sono uno stimolo a una riflessione non affetta da provincialismo.Ecco il testo di Portoghesi alla voce “Botta”.
Verso la metà degli anni settanta di passaggio per Stoccarda, dopo aver tenuto una conferenza, mi capitò di entrare per caso in un’aula della facoltà di architettura .
Un gruppo di studenti stava proiettando diapositive realizzate durante un viaggio nel Canton Ticino: in gran parte opere di Botta, quelle immagini erano accompagnate da musiche di Beethoven.
Ebbi la sensazione precisa che le qualità delle architetture di Botta, il loro carattere compositivo, corrispondessero alla permanente popolarità della musica classica, al bisogno “moderno”di non perdere il legame con la regolarità e la forza della musica tonale.
L’architetto ticinese esordisce in modo felice con una casa in Riva San Vitale, del 1971-73 e rapidamente s’impone all’attenzione per la capacità di realizzare architetture la cui genesi geometrica è ben leggibile nell’opera compiuta.
Nelle case poi realizzate negli anni ‘80 il tema della regolarità geometrica e dell’introduzione nel paesaggio di forme autosufficienti e riassuntive gli permette di recuperare alcuni aspetti della tradizione palladiana.
Dopo l’intenso lavoro dedicato al tema della casa, Botta ripropone, in edifici di diversa destinazione e dimensione, la morfologia del cubo e del cilindro, ma di solito non riesce a recuperare la felicità espressiva e capacità di controllo che caratterizza le prime opere , spesso evidenziando la forzatura che la scelta a priori del modello volumetrico impone all’organismo spaziale.
Botta non gradisce di essere inserito nella categoria del Post-moderno, ma la sua opera possiede molte delle caratteristiche che la critica ha attribuito a questa categoria, in particolare il recupero di elementi morfologici tipici del linguaggio classico come l’arco, la colonna, il capitello, la scala assiale, la volta a botte, l’impianto simmetrico, anche se escludono la citazione, coincidono con un linguaggio basato su convenzioni che legano il presente al passato.
L’autore ne offre spesso una motivazione funzionale o costruttiva, ma raramente si tratta di elementi legati al contesto e spesso rappresentano una caratteristica del gusto con cui il progettista propone la sua immagine. Sono impiegati con la metodologia propria del Postmoderno ed echeggiano le opere di Graves e Moore, anche se in Botta l’esigenza dell’astrazione è annunciata in modo apodittico.
A suo vantaggio troviamo la riscoperta del primato della qualità estetica, che rappresenta la motivazione che giustificava l’entusiasmo dei giovani a Stoccarla e che resta la migliore testimonianza del suo periodo felice.
Se all’inizio degli anni ottanta la figura emergente di Botta faceva sperare nella sua capacità di interpretare e perpetuare la lezione di Louis Khan, contribuendo a riconnettere la tradizione del nuovo con la tradizione storica, la ricchissima produzione dell’ultimo decennio ha fortemente ridimensionato tali speranze.
Prigioniero di una formula compositiva di indubbia efficacia, l’architetto l’ha ripetuta fino alla stanchezza, prelevando dalla eredità storica non ciò che poteva dare alle sue immagini delle radici nel luogo con una connessione tipologica, ma ciò che volta a volta era più adatto a dare all’immagine una sorta di potere ipnotico.
E’ il caso in particolare della chiesa di Mogno, in cui la scala del palazzo comunale di Gubbio viene riproposta in modo incongruo e poggiata sul vuoto, o il cilindro mozzato in diagonale riproposto a San Francisco o a Evry dove appare coronato da chiome di alberi in discesa come clienti delle montagne russe. Così queste architetture che partono da un involucro semplice prestabilito – il cono, il cubo o il cilindro – si riducono spesso a oggetti galleggianti in uno spazio al quale non appartengono, strenuamente elaborati e tormentati da un furor arcisimmetrico per cui nulla si sposta a sinistra senza che si produca a destra uno spostamento corrispondente, dando la sensazione di organismi anchilosati.
Per di più questo inaridimento è parallelo ad atteggiamenti di un protagonismo intellettuale violentemente narcisistico in aperto contrasto con la dimensione artigianale che aveva caratterizzato il suo felice esordio. Ne è esempio eloquente il libro di Jean Petit, in cui il volto dell’architetto è riprodotto 156 volte in fotografie che lo ritraggono in tutte le pose e le compagnie possibili, ad onta dei lineamenti inespressivi e un po’ grossolani alla vista dei quali la enfatica capigliatura non riesce a distrarre l’osservatore.
Paolo Portoghesi – I grandi architetti del novecento
Newton Compton Editori (1998)
È docente di letteratura italiana all’Università La Sapienza di Roma dal 1962 al 1967 e, dal 1967 al 1977, di storia dell’architettura al Politecnico di Milano dove è poi nominato preside nel 1968. Dal 1995 insegna progettazione architettonica all’Università di Roma.